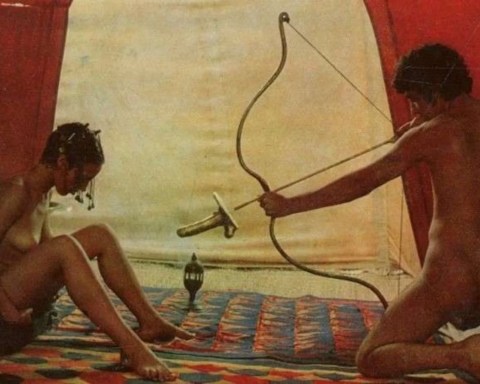Un cinema mirabile e inquieto, apparentemente riposante perché condito da musica scelta, ordinata, da colori pastello (Le bonheur) e chiaroscuri decisi, sfumati solo nel montaggio alternato (Le Pointe Courte, Salut les cubains). Les plages d’Agnès è un’opera estranea a imposizioni, noncurante di categorie e steccati, oltre corrente «più che controcorrente» [1].
«Les plages d’Agnès»: racconto del sé e centralità dell’immagine

Agnès Varda cammina al fianco della storia, l’attraversa col corpo, con lo strumento proteiforme della cine-fotocamera puntata sui dettagli, come creatura insidiosa della notte, faro e sismografo del mondo che va cambiando. Sempre autobiografica – mai egocentrica – costruisce e disseziona a partire da sé, rendendo l’esperienza il nerbo di un discorso ampliabile, ripreso e perfezionato di prova in prova, con indefettibile coerenza.
Leggi anche:
Il Grinta, ovvero l’opera che ha consacrato John Wayne
Varda è un’artista visuale nel senso pieno del termine, elegge l’immagine a mezzo d’azione, presentandola al contempo come un referto impietoso, documento parlante di una realtà fissata con sguardo fresco, non filtrata da riscritture o ansie citazionistiche. Il richiamo all’arte, il metacinema o l’affinità con certe pratiche coeve (l’incomunicabilità di Antonioni, l’osmosi à la Rossellini tra personaggi e ambiente) sono semmai il risultato di una stagione creativa feconda, vissuta trasversalmente da campioni con percorsi divergenti, quali – fra tutti – i ragazzi della Nouvelle Vague, cui Agnès è accomunata per ragioni di etichetta, secondo l’invalsa tendenza alla categorizzazione della singolarità.
Lo sguardo non filtrato

Ciò che distingue l’autrice dai suoi «compagni di strada» è proprio l’occhio con cui abbraccia le cose del mondo, non più mezzo di «riflessione straniata sul visibile/filmabile», come per Godard o Rohmer)[2], ma rapporto diretto, finanche intimo, studiato nei minimi dettagli ma scevro da pretese scientifiche, lontano dalla strenua ripartizione tra oggetto guardato e soggetto che guarda. L’immagine è il presupposto, lo strumento e il fine della sua opera. Lei stessa si fa figura quando alla Biennale di Venezia del 2003 appare nelle vesti di patata vivente, a presentare la sua prima installazione video (Patatutopia), che rivela un’inclinazione performativa già sottesa a certe opere, le stesse che presentano analogie con le prospettive di Chris Marker.
Leggi anche:
Giuseppe Tornatore: per sognare un nuovo cinema paradiso
Come il collega, Varda realizza un cinema di carpenteria, in cui le possibilità del linguaggio audiovisivo vengono sfruttate appieno, secondo un’ottica in cui il frammento, l’installazione e il fotogramma assumono valore di preciso scandaglio. Nessuna presunzione d’assoluto: le immagini che prendono corpo sono, per dirla con Marchese, «l’unità minima del cinema della Varda», dei ritagli «spigolati»[3] da quel caos variamente formato che è la realtà.
Il cinema come spigolatura

Il richiamo alla spigolatura è funzionale alla comprensione di una certa idea di opera, visivamente sintetizzata in Les glaneurs et Le glaneus, dove l’antica pratica di raccolta si fa metafora di un procedere intellettuale, parimenti emotivo e ragionato. I prodotti difformi dallo standard di mercato vengono scartati perché invendibili, appaiono difettosi come le patate della Biennale, monchi, rugosi, disadattati. Agnès Varda ne opera il riscatto, raccoglie i cascami come fossero gemme e tramite l’immagine cataloga «porzioni di cine-mondo»[4] intense e rivelatorie.
Leggi anche:
Figli, Mattia Torre ci ha liberato dalla famiglia Mulino Bianco
È qui che si annida la coerenza del suo lavoro. La disposizione dei frammenti sulla messa in scena le consente di parlare attraverso le azioni altrui, di mettere insieme pezzi di memoria alimentando la propria. Come un percorso a tappe, lo sbocco naturale di tale pratica si concretizza – o meglio, si racconta – nell’autobiografia filmica Les plages d’Agnès, un racconto di osmosi e giustapposizioni, la ri-scoperta di sé intesa come disvelamento à rebours.
La presenza di Demy

Qui i fotogrammi divengono tessere di un mosaico, parti di un insieme armonico che attinge alle pellicole come a un album di famiglia, coi personaggi filmici affiancati agli affetti della Varda, dai figli Rosalie e Mathieu al compagno Jacques Demy. Il suo ricordo aleggia tra i luoghi eletti a sede dell’anima, spiagge come frazioni di un tempo memoriale rigoroso, identificabile dallo spettatore ora con l’infanzia (il mare del Nord) e la giovinezza (Sète), ora col periodo bellico e gli anni da studentessa (la Corsica). Le storie di mare si moltiplicano, ciascuna costituisce una speciale stanza dell’esistenza, costruita sul dolore con cui Varda si riappacifica.
Leggi anche:
In the Mood for Love, 20 anni del capolavoro di Wong Kar-wai
Jacques è un vento d’amore e nostalgia, «il più caro dei morti» che l’amica, collega, amante rammenta con pudore, quasi ampliando l’omaggio tributatogli con Jacquot de Nantes. Per lui c’è la spiaggia di Noirmoutier e poi quelle d’oltreoceano, Los Angeles e Venezia come utopia e disincanto.
«È meglio morire in due. Viaggiavamo insieme, andavamo insieme in spiaggia e ai musei, frequentavamo gli amici e patatrac, Jacques si è ammalato di una malattia mortale».
Il compagno è un dato che torna, sollecitato da associazioni d’immagini che ne svelano la presenza muta.
Amore e attitudine performativa

L’amore è comunque un tema caro alla Varda, declinato in straordinario anticipo sui tempi e a tratti sviscerato nell’apatia più scabrosa, come nell’esordio de La Pointe Courtre di cui proietta, qui, le scene preparatorie mai mostrate in pubblico. Il flusso dei ricordi la porta dal borgo dei pescatori a una spiaggia del nord, «tutti i ragazzi che amo e tutti gli uomini che guardano il mare si chiamano Ulysse». Di passioni e lacerazioni l’autrice parla senza infingimenti. Tra le confessioni dell’autobiografia c’è la relazione con Antoine Boursellier (padre di Rosalie) attore in Clèo de 5 à 7 e vuoto affettivo transitorio.
Leggi anche:
Il Divo, ovvero i meccanismi del potere
È l’impermanenza dello sconforto uno dei fili rossi de Les plages d’Agnès, giacché da ogni mancanza Varda ritrova energia, la sua voce accompagna lo spettatore nei meandri un’esistenza anomala, piena di grazia e fulgore. La commistione tra mondo reale e mondo mentale trova qui il suo vertice, costituendo il segno di una coerenza indomita e l’impalcatura stilistica con cui narrare l’universo-Varda. Tutto è giocoso, per lo più colorato, e il carattere performativo conferisce al discorso sul sé un alone fiabesco. Da patata parlante l’artista si fa ora sagoma, incastonata in corpi di cartone o in cornici vuote, posizionate sulla sabbia come ne La bella prigioniera di Magritte.
«Les plages d’Agnès»: un caleidoscopico archivio dell’esistenza

Ecco la forza dell’installazione. Al pari dell’opera del pittore belga, la realtà esiste simultaneamente nel paesaggio e nella mente di chi osserva. Gli specchi stessi, così ricorrenti nell’opera di Varda, riflettono un mare che s’infrange contro di essi, testimonianza della diffrazione identitaria operata sul sé dagli sguardi esterni. La scelta di comporre un film artigianale, in cui gli oggetti più futili assumono un’importanza estrema, conferisce a Le plages d’Agnès il carattere di un archivio da preservare e dissotterrare.
Leggi anche:
Moretti vs Monicelli: cosa ci insegnò quello scontro epico
Spigolando qua e là, fra le pieghe del vissuto, la cineasta ci prende per mano senza imporre un orientamento. A saldare i dati artistico-memoriali interviene l’io intradiegetico, collocato in un oggi rimemorante che tiene assieme frazioni di tempo, episodi e prodotti altrimenti distanti. «Mi ricordo mentre vivo», chiosa Varda. Le spiagge sono un caleidoscopio, porzioni cangianti di una realtà smembrata e di una vita imprevedibile.
Note:
[1] N. Falcinella, Agnès Varda. Cinema senza tetto né legge, Genova, Le Mani, 2010, p. 11.
[2] L. Marchese, Agnès Varda, cine-spigolatrice, in Ivi, p. 45.
[3] Ivi, p. 46.
[4] Ibidem.
Seguici su Instagram, Facebook e Telegram per scoprire tutti i nostri contenuti!